Obiettivi
L’iniziativa di predisporre una guida per la creazione di startup cooperative nasce dalla necessità di promuovere politiche di auto imprenditorialità capaci di favorire l’occupazione giovanile, di incentivare l’adozione della forma cooperativa tra le imprese di nuova costituzione, di affermare la presenza della cooperazione in nuovi mercati e nel campo dell’innovazione, tecnologica e sociale. Incoraggiare e sostenere le startup cooperative significa non solo creare imprese e posti di lavoro, ma anche favorire l’innovazione – generando un rinnovamento dell’offerta e raggiungendo aree di domanda insoddisfatta o inesplorata – e incentivare processi di formazione di una nuova imprenditorialità, facendo perno sul sistema cooperativo, sulle nuove generazioni e sull’esperienza e riqualificazione di quelle mature.
Terminologia
Startup significa avviare, ma il termine è, generalmente, utilizzato sia in senso letterale (per indicare la fase iniziale di un’impresa o di avvio di una specifica attività all’interno di un’impresa già esistente), sia in senso figurato (per indicare aziende che introducono nel mercato, direttamente o tramite imprese collegate, prodotti a forte contenuto innovativo con l’obiettivo di raggiungere in tempi rapidi alti profitti) (1).
In questi ultimi anni, di fronte alla crisi economica e alla crescita della disoccupazione, anche influenzati dalle esperienze statunitensi e israeliane, il termine è entrato nel linguaggio comune perché nelle startup si vede la possibilità di creare nuove opportunità occupazionali, soprattutto per i giovani, in ambiti di mercato emergenti, sfruttando soprattutto le tecnologie informatiche. Nel concreto, nonostante i chiarimenti presenti nella recente produzione normativa italiana (da Restart Italia al Decreto Crescita 2.0)(2), la distinzione tra startup innovative e startup tout court sembra perdere di senso tanto che, nelle esperienze pubblicizzate dalla stampa o presentate in occasione di incontri e convegni, diviene sempre più difficile discernere tra proposte che si basano su invenzioni (il più delle volte geniali, ma con scarsa rilevanza economica), imprese innovative (che sfruttano a fini economici le invenzioni introducendo innovazioni) e imprese nuove (che combinano in modo originale mezzi e strumenti esistenti o che puntano ad introdurre nuovi sistemi di offerta).
Il significato di startup che adottiamo in questo lavoro si riferisce all’avvio di un’attività di impresa ed al suo consolidamento in forma cooperativa. Ci focalizzeremo sulla cooperativa di lavoro (il cui rapporto mutualistico si realizza attraverso il lavoro del socio) in quanto il fine che ci proponiamo è di creare occupazione duratura e di qualità per coloro che hanno in mente un’idea imprenditoriale e si propongono di realizzarla collaborando con altri. Ciò non significa limitare il campo d’azione ai mercati tradizionali e tenersi lontano da ambiti innovativi. Al contrario, la creazione di nuova imprenditorialità cooperativa richiede – ed è – essa stessa innovazione. L’innovazione, infatti, può assumere forme diverse, potendo spaziare:
- dall’introduzione o adattamento di una soluzione nuova ad un contesto tradizionale (sviluppo di un processo/prodotto “nuovo” – più efficace, più economico, di nicchia – rivolto ad un mercato esistente),
- all’innovazione radicale, quella cioè che rivoluziona un prodotto o un processo e crea un mercato (sviluppo di un processo/prodotto “nuovo” – che incorpora vere e proprie innovazioni – rivolto ad un mercato che ancora non esiste) (3).
Il percorso proposto è in sintonia sia con il dibattito in corso a livello specialistico, sia con gli orientamenti dell’Unione Europea che, nel contesto della strategia Europa 2020, individuano nell’innovazione, nella compatibilità ambientale e nella crescita dell’occupazione le priorità per la realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Nella strategia europea, Horizon 2020 rappresenta l’elemento portante per l’attuazione dell’Unione dell’innovazione e prevede un sistema di fondi orientato a realizzare le priorità economiche e politiche della strategia europea. Horizon 2020 ha, tra l’altro, l’obiettivo di stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione per la realizzazione di attività in determinati ambiti strategici, funzionali a rispondere alle preoccupazioni dei cittadini. Il finanziamento europeo diretto è incentrato sulle seguenti aree:
- salute, cambiamenti demografici e benessere;
- sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia;
- energia sicura, pulita ed efficiente;
- trasporti intelligenti, ecologici e integrati;
- azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime;
- società inclusive, innovative e sicure.
Questi sono ambiti in cui si può pensare di sviluppare attività imprenditoriali future, sia perché sono considerati cruciali per l’introduzione di innovazioni, sia perché su di essi si concentreranno gran parte delle risorse europee. Nell’ambito della strategia Europa 2020, tuttavia, la nascita di nuove imprese è auspicata anche in altri settori, come, per esempio, l’agricoltura, in relazione ad attività di miglioramento della qualità del territorio e della coesione sociale. Stesso favore è riservato agli ambiti della salvaguardia e della fruibilità del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico e paesaggistico che mirano a sollecitare lo sviluppo delle industrie culturali e creative e nuove forme di promozione e valorizzazione turistica del territorio.
Sostanzialmente sono considerate foriere di crescita e occupazione tutte quelle attività che mirano ad uno sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista ambientale, che della rigenerazione delle risorse utilizzate nelle produzioni, che dell’inclusione sociale, tanto più auspicabili quanto più basate sull’introduzione di innovazioni.
Metodologia
Le elaborazioni fino ad ora effettuate con il progetto Coopstartup suggeriscono di distinguere chiaramente tra due momenti di vita delle startup.
Il primo riguarda la fase di pre-startup, quella in cui la startup è il punto di arrivo e porta alla nascita della nuova impresa. La seconda riguarda il post-startup in cui la startup è il punto di partenza verso un ulteriore consolidamento e sviluppo dell’attività aziendale.

L’oggetto di questo documento è diretto all’analisi della prima parte del ciclo di vita delle startup cooperative, sia per priorità logiche, sia perché una maggiore solidità nelle fasi che precedono la costituzione formale e l’avvio delle attività riduce l’emergere di problemi successivi e minimizza il rischio di mortalità. Sono previsti, tuttavia, sviluppi futuri del lavoro, orientati a supportare specificamente startup cooperative nei primi anni della loro vita.
Scopo di questa guida è, quindi, delineare le diverse fasi del processo di avvio di una cooperativa e suggerire un percorso per la trasformazione di idee progettuali in attività economiche sostenibili e di lungo periodo. Nel far ciò si è posta particolare attenzione a gran parte dei problemi che concretamente devono essere affrontati e risolti nella creazione dell’impresa. Evidentemente sono stati trattati gli aspetti che in generale si presentano, lasciando all’azione successiva che porterà alla costituzione della cooperativa e alle sue prime fasi gestionali la realizzazione degli adempimenti amministrativi, fiscali, autorizzativi e, in generale, delle attività gestionali su cui esistono testi specializzati e consulenti specifici.(4)
Da un punto di vista strettamente imprenditoriale, creare una cooperativa non è molto differente da avviare un qualsiasi altro tipo d’impresa. Tuttavia, il processo di formazione presenta alcune specificità, prima fra tutte la necessità di coinvolgere in modo partecipativo e democratico e, preferibilmente, fin dai primi stadi, un numero di persone maggiore di quello caratteristico di ogni altro tipo d’impresa: per una cooperativa, quindi, non si tratta solo di dare corpo all’intuizione imprenditoriale di un individuo, ma di impostare un progetto condiviso che dalla sua prima formulazione garantisca il contributo d’ingegno, tempo e professionalità di un gruppo. Distingue la cooperativa da altre forme di impresa l’essere un’organizzazione collettiva di cui fanno parte almeno tre persone, che contano in quanto singoli individui e non per il capitale apportato, che prendono le decisioni democraticamente e che si assumono collettivamente le responsabilità.
Il principale target di riferimento di questa guida sono gli aspiranti cooperatori, soprattutto giovani, ma alcune suggestioni potranno essere utilizzate anche dalle strutture territoriali del sistema Legacoop per verificare/adattare/rafforzare i servizi di supporto attualmente esistenti. Abbiamo, infatti, raggiunto la consapevolezza che, al fine di creare imprese solide e con buone prospettive di vita e non semplici iniziative rispondenti a fantasiose ed instabili opportunità di speculazione economica, i team di aspiranti cooperatori hanno necessità di una rete di sostegno capace di guidarli, indirizzarli e accompagnarli nei percorsi di realizzazione delle loro idee imprenditoriali.
Questo documento va adattato alla situazione contingente, tenendo conto degli aspetti di carattere personale, psico-sociologico, economico, tecnologico, di mercato e di contesto più complessivo (l’impresa come sistema socio-tecnico aperto, secondo l’impostazione del Tavistock Institute). Quanto più piccola è la dimensione (sia in termini di complessità che in termini di quota di mercato utile per raggiungere il break even point(5)) più sono decisivi fattori soggettivi come l’attitudine imprenditoriale, la qualità delle relazioni fra le persone, le aspettative individuali. Il concetto che vogliamo esprimere può essere rappresentato con la seguente matrice(6), che mette in relazione la dimensione del progetto con la rilevanza dei fattori specifici/individuali.
|
|
ARTISTI
|
PIONIERI
|
||
|
Fattori specifici/individuali |
||||
|
GESTORI
|
ORGANIZZATORI
|
|||
|
– |
||||
|
|
– |
|
+ |
|
La guida vuole essere uno strumento agile e di facile lettura; le indicazioni fornite, tuttavia, devono essere precise e circostanziate evitando un linguaggio troppo tecnico, ma anche eccessive semplificazioni che rischierebbero di renderle banali.
Lo schema suggerito segue l’impostazione del documento “Simply Startup. A guide to the process of starting a Co-perative or Community Enterprise”, Co-operatives UK, 2011 (di cui è stata richiesta e concessa l’autorizzazione all’uso(7)), ma è stato modificato e adattato, soprattutto considerando le riflessioni emerse nell’ambito del Gruppo di Progetto Coopstartup, per renderlo più aderente alla nostra realtà.
Il percorso proposto parte dall’idea e giunge fino alla creazione della startup cooperativa. Si tratta di un percorso logico strutturato in dieci fasi:
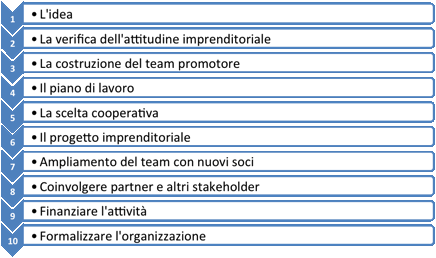
L’itinerario suggerito non corrisponde necessariamente ad una sequenza ordinata di passi operativi: alcune fasi possono assumere carattere trasversale ed essere svolte durante tutto il processo, seguendone la sua maturazione; altre fasi, invece, possono assumere carattere ricorrente, nel senso che in alcuni casi lo sviluppo dell’idea potrà richiedere di ripensarne alcuni aspetti e riprogettare fasi specifiche che sembravano risolte o superate, con l’implicazione di dover ripercorrere parte del processo su basi nuove. La rappresentazione non lineare del processo suggerito, che tocca tutte le fasi e mostra le differenti interconnessioni, è la seguente:
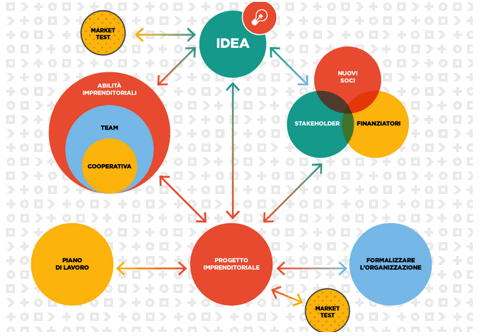
Per ogni fase si presenta una breve descrizione e quattro sezioni dirette principalmente ad agevolare l’autoanalisi dei neoimprenditori cooperativi, ma anche a suggerire strumenti e azioni di supporto. Le quattro sezioni riguardano:
- Domande chiave: sono alcune domande che i neocooperatori dovrebbero porsi per focalizzare l’attenzione sugli elementi distintivi della fase.
- Risultati da raggiungere: costituiscono gli obiettivi che i neocooperatori dovrebbero realizzare per concludere la fase.
- Strumenti utilizzabili: sono esempi di strumenti e tecniche di supporto ai neocooperatori per l’analisi e la valutazione di aspetti specifici.
- Supporto necessario: riguardano esempi di azioni e servizi che potrebbero essere attivati come rete di sostegno.
La sezione “supporto necessario” va analizzata nella sua complessità. E’ richiamata fase per fase, ma, considerando la sostanziale omogeneità del complesso dei servizi da offrire (informazione, formazione, consulenza), potrebbe essere progettata con la costituzione di un “punto unico di accesso” (figure preposte ad accompagnare i promotori dell’idea imprenditoriale nel processo) in cui ottenere specifiche informazioni e conoscere le opportunità messe a disposizione per lo sviluppo del processo e attivabili facendo riferimento ad esperti e consulenti interni o accreditati del sistema Legacoop.(8)
1. Si fa riferimento alla fonte europea accreditata IATE, InterActive Terminology for Europe.
- Nascita Nuova Impresa (Start-up): nuova impresa (nella cui attività i fattori produttivi non derivano da un’altra azienda) nella fase di avviamento. Ha rilevanza sul Registro delle Imprese. Il termine può essere anche usato nel senso di fase iniziale di sviluppo di un’impresa. “A new business venture”
- Start-up Innovative (Innovative start-up): Aziende capaci di svilupparsi a tassi di crescita molto alti in periodi di tempo molto contenuti. Le imprese high-growth hanno due caratteristiche fondamentali: sono imprese capaci di crescere a ritmi molto elevati, che spesso comportano la duplicazione delle dimensioni aziendali, e sono imprese che hanno una crescita concentrata in un periodo di tempo che oscilla tra quattro e cinque anni. “A company with annual sales revenue that has grown 20 percent or more for four straight years”.
Posseggono il requisito dell’innovazione e dell’autonomia societaria alcune tipologie assimilabili quali:
- spin-off universitari (società con la partecipazione dell’università in qualità di socio);
- spin-off accademici (società in cui università non ha quote di partecipazione);
- società di alta tecnologia (dgls 297/99 su sostegno ricerca scientifica e tecnologica e successivi provvedimenti).
Vi sono altri processi che creano “un’unità figlia con risorse, anche limitate, dell’unità madre” (Istat), non identificabili direttamente come startup, quali, per esempio (fonte: Eurostat e OCSE – Typology of Demographic Events Eurostat − OECD Manual on Business Demography Statistics):
- Scorporo d’azienda (Spin-off): la divisione di una parte dei beni di un’azienda (che sopravvive) in una nuova entità giuridica (che si costituisce), i cui titoli sono distribuiti ai detentori delle quote azionarie della società originaria. “A business, organization, developed out of or by (former) members of another larger business” oppure “The creation of an independent company through the sale or distribution of new shares of an existing business/division of a parent company. A spinoff is a type of divestiture (dismissione, ndr)”.
- Acquisizione d’azienda (Change of ownership): passaggiodi proprietà delle azioni o delle quote aziendali. Non costituisce nuova azienda salvo nel caso in cui vi sia trasformazione da SPA o SRL in cooperativa, come nel caso di:
- acquisizione del pacchetto di maggioranza dell’impresa da parte di dirigenti – Manager Buy Out (MBO): “Financing provided to enable current operating management and investors to acquire an existing product line or business”.
- acquisizione del pacchetto di maggioranza dell’impresa da parte dei dipendenti –Employee buy Out (EBO), assimilabile al più conosciuto Workers Buy Out (WBO): “restructuring strategy in which employees buy a majority stake in their own firms”.
2.A seguito della legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” viene introdotta la denominazione Startup Innovativa, con le seguenti caratteristiche istitutive:
- società di capitali, costituite anche in forma cooperativa
- non quotate, detenute e controllate almeno al 51% da persone fisiche
- sede principale in Italia
- meno di 4 anni di attività
- fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
- non distribuiscono utili
- contenuto innovativo identificato con:
- almeno 20% spese in ricerca e sviluppo
- almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori
- startup titolare o licenziatario di brevetto
È definito l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, per assicurare massima trasparenza sui dati delle startup.
Nella categoria delle startup innovative rientrano le startup innovative a vocazione sociale che, oltre a rispettare i requisiti sopra elencati, si caratterizzano per svolgere la loro attività in via esclusiva in settori di utilità sociale (assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza sociosanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extrascolastica, servizi strumentali alle imprese sociali)
3.Per una definizione di innovazione ampiamente riconosciuta si può far riferimento al glossario predisposto dall’Istat (Dicembre 2012) per la Rilevazione statistica sull’Innovazione nelle Imprese, Anni 2008-2010. Stante la funzione svolta dall’Istituto nazionale di statistica e l’uso che viene fatto delle sue rilevazioni da parte dello Stato e degli istituti di ricerca e da quelli della programmazione, riteniamo queste definizioni idonee ai nostri fini.
- Attività innovative: attività che si rendono necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati). Sono da considerarsi attività innovative: la ricerca e sviluppo (R&S), inclusa la ricerca di base; l’acquisto di macchinari, attrezzature, software e licenze; la progettazione (design); la formazione del personale per attività di innovazione; il marketing di prodotti e servizi innovativi; altre attività preliminari alla realizzazione di innovazioni di prodotto, servizio e processo.
- Innovazioni di prodotto: consistono nell’introduzione sul mercato di prodotti o servizi nuovi (o significativamente migliorati) in termini di caratteristiche tecniche e funzionali, uso di materiali e componenti, prestazioni, facilità d’uso, ecc., rispetto ai prodotti e servizi correntemente realizzati e offerti sul mercato dall’impresa. L’innovazione di prodotto o di servizio non deve necessariamente consistere in prodotti o servizi nuovi per il mercato in cui opera l’impresa; è infatti sufficiente che prodotti e servizi risultino nuovi per l’impresa che li introduce. L’innovazione di prodotto o di servizio può essere sviluppata dall’impresa stessa o da altre imprese o istituzioni. Sono esclusi: i prodotti modificati solo marginalmente; le modifiche di routine e le modifiche periodiche apportate a prodotti e servizi esistenti; le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici (come per le linee di abbigliamento); la personalizzazione dei prodotti diretta a rispondere alle esigenze di specifici clienti; le variazioni nelle caratteristiche estetiche o nel design di un prodotto che non determinano alcuna modifica nelle caratteristiche tecniche e funzionali dello stesso; la semplice vendita di nuovi prodotti o servizi acquistati da altre imprese.
- Innovazioni di processo: consistono in tecniche di produzione, sistemi di logistica, metodi di distribuzione o attività di supporto alla produzione tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati). Tali innovazioni sono introdotte al fine di rendere l’attività aziendale economicamente più efficiente, migliorare gli standard di qualità e la flessibilità produttiva o ridurre i pericoli di danni all’ambiente e i rischi di incidenti sul lavoro. Sono esclusi: i processi modificati solo marginalmente; l’incremento delle capacità produttive mediante l’applicazione di sistemi di fabbricazione o di logistica molto simili a quelli già adottati.
- Innovazioni organizzative: consistono in mutamenti significativi nelle pratiche di organizzazione dell’impresa, nei metodi di organizzazione del lavoro, nelle relazioni pubbliche con altre imprese o istituzioni pubbliche. Sono esclusi: i mutamenti nelle strategie aziendali, salvo che non siano accompagnati da cambiamenti organizzativi significativi; l’introduzione di nuove tecnologie in una sola divisione aziendale (ad es. nel reparto produzione).
4. A titolo di esempio, rinviamo ad un testo di recente pubblicazione che, pur non affrontando specificatamente la tipologia cooperativa, è, a nostro avviso, un ottimo ausilio allo startup concentrandosi sul metodo e sul processo necessari a realizzare un’impresa. L’autore, tra l’altro, ha manifestato interesse a Coopstartup e disponibilità a una piena collaborazione.
Marco Travaglini, Alfabeto per la creazione di impresa, Bologna, 2014, Fausto Lupetti Editore
5. Il punto di pareggio (break even point o break even, abbreviato in BEP) è un valore che indica la quantità, espressa in volumi di produzione o fatturato, di prodotto venduto, necessaria a coprire i costi precedentemente sostenuti, al fine di chiudere il periodo di riferimento senza profitti né perdite.
6.Elaborata da Flavio Casetti, vicepresidente di Seniorcoop (l’associazione dei dirigenti cooperativi in pensione – impegnati a titolo volontario in attività di promozione e sviluppo della cooperazione).
7.Si ringrazia Ed Mayo, Segretario Generale di Cooperatives UK, per aver accolto con cortesia e disponibilità la nostra richiesta e Stefania Marcone dell’Ufficio Esteri di Legacoop per aver gestito la relazione.
8.Due strumenti di Legacoop nazionale fondamentali sono CAPACE2014 – Servizi personalizzati e garantiti nel nuovo patto associativo http://www.legacoop.coop/introcapac/ e la Rete Nazionale Servizi http://www.legacoop.coop/rns/
